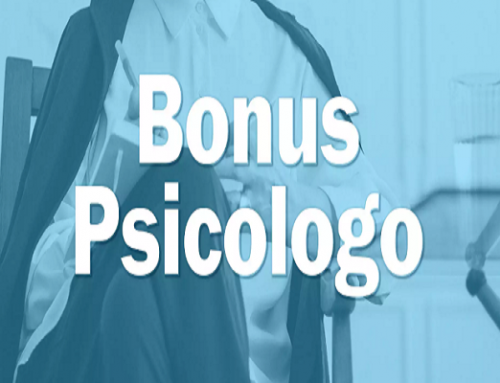Secondo un’analisi condotta da uno scienziato della University of Pittsburgh School of Medicine e pubblicata su Nature Communications, il vocabolario che si usa per descrivere le proprie emozioni è un indicatore della salute mentale e fisica, quindi del benessere generale della persona.
“Il nostro linguaggio racconta la nostra esperienza riportando gli stati emotivi con cui siamo più a nostro agio”, ha detto l’autore principale dello studio, Vera Vine, Ph.D., “dai nostri studi sembra che ci sia una congruenza tra il numero di modi diversi in cui possiamo nominare una sensazione e la frequenza e la probabilità con cui sentiamo quella sensazione”.
Per esaminare come la profondità del vocabolario delle emozioni corrisponda all’esperienza vissuta, Vine e il suo team hanno analizzato i blog pubblici scritti da oltre 35.000 persone e i saggi sul flusso di coscienza di 1.567 studenti universitari. Gli studenti hanno anche auto-riferito i loro stati d’animo periodicamente (durante tutto il tempo di durata dell’esperimento) tramite dei questionari appositi usati per lo screening della Depressione.
Nel complesso, le persone che utilizzavano una più ampia varietà di parole in riferimento ad emozioni negative, tendevano a mostrare marcatori linguistici associati a un minore benessere, come i riferimenti alla malattia e allo stare da soli, e mostravano atteggiamenti depressivi, nonché una salute fisica peggiore. Al contrario, coloro che usavano una varietà di parole orientate ad emozioni positive, tendevano a mostrare indicatori linguistici di benessere – come riferimenti ad attività ricreative, risultati e appartenenza a un gruppo, rportando tassi più elevati di coscienziosità, estroversione, gradevolezza, salute generale, e indicatori più bassi di depressione e nevroticismo.
Durante l’esercizio sul flusso di coscienza, Vine e colleghi hanno scoperto che gli studenti che hanno usato più parole per la tristezza sono diventati più tristi nel corso dell’esperimento; le persone che hanno usato più vocaboli tipici per descrivere la paura sono diventate più preoccupate; le persone che usavano più parole per indicare rabbia, hanno sviluppato una maggiore tensione.
Il tutto sembra confermare il legame inscindibile tra esperienza e racconto, il fatto che l’uomo per sentirsi consapevole e inserito (oltre che ovviamente “emozionato”) in una realtà organizzata temporalmente e coordinata, abbia bisogno di narrare storie (fantastiche o verosimili, al momento, poco importa). Altresì, la consapevolezza dell’esistenza di questi meccanismi, accrescono la rilevanza di quegli orientamenti psicoterapeutici che vedono nell’ermeneutica e nell’analisi della narrazione, la modalità principale di approccio al paziente.
“È probabile, a questo punto, che le persone che hanno avuto esperienze di vita più sconvolgenti abbiano sviluppato vocabolari più ricchi di emozioni negative per descrivere i mondi che li circondano”, conclude James W. Pennebaker, Ph.D., professore di psicologia presso l‘Università del Texas ad Austin e autore del progetto di ricerca.
Riferimenti