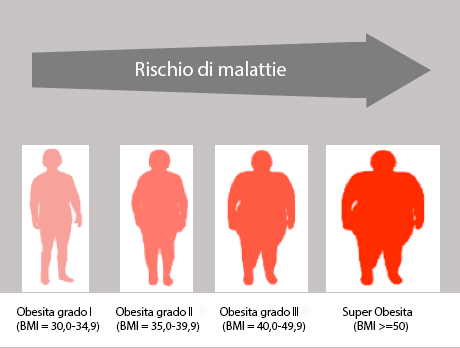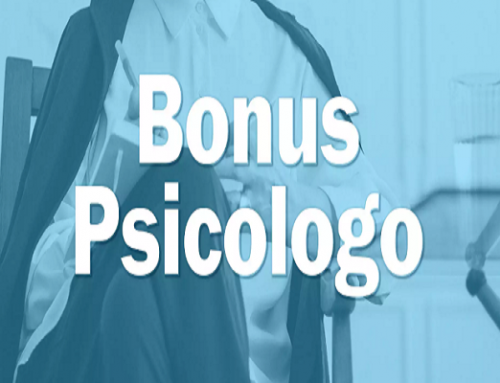Per la fenomenologia, disciplina alla quale si ispira la Psicoterapia Cognitiva-Neuropsicologica, mio approccio terapeutico in ambito clinico, il corpo è unico luogo possibile dell’esperienza, della “mia esperienza”, costituendo la base di partenza e di arrivo di ogni atto riflessivo. Ogni persona è consapevole di sé stessa immediatamente perché avente un corpo (organico) vivo. Ogni corpo vivo gode di una precisa collocazione sia spaziale che temporale e attorno ad esso si raggruppa e dispiega l’ambiente sensibile. Indipendentemente da “dove” si trovi e da “quando” percepisca, ogni corpo vivo comprende, chiaramente, come l’ambiente, attorno a lui, sia limitato. Limitato sia da parametri spaziali sia da parametri temporali, ma nonostante questo, gli ambienti vengono sempre percepiti, direttamente, o tramite ricordi intenzionali.
L’aspetto culturale diviene determinante nel processo di costruzione dei significati che ruotano attorno all’idea del corpo ed in tal senso il corpo reale, immaginato o desiderato, può essere considerato l’origine, ma anche il punto di arrivo di differenti forme di disagio. Esso può alimentare vissuti di profonda sofferenza e insoddisfazione o interferire con il senso d’identità, tanto da indurre una persona a identificarsi con il proprio disturbo: “io sono la mia malattia”. In questi casi diventa fondamentale comprendere come il corpo venga inteso dalla persona e quali filtri utilizzi per descriverlo.
Questa digressione serve da premessa al tema dell’obesità, una condizione medica caratterizzata da un eccessivo accumulo di grasso corporeo che può portare effetti negativi sulla salute con una conseguente riduzione dell’aspettativa di vita. Come l’anoressia, l’obesità patologica sembra inscriversi nel registro dell’evidenza. Il corpo magro dell’anoressia e il corpo grasso dell’obesità fanno segno ad una clinica dello sguardo: il corpo del soggetto è il luogo evidente in cui si rende manifesta una alterazione. Nondimeno, se l’evidenza anoressica si presenta come paradossalmente adeguata all’Ideale (sociale) del canone estetico, quella dell’obesità colpisce per il suo carattere di non accettazione. Se l’immagine del corpo-magro dell’anoressica può suscitare nella persona sofferente consenso e integrazione, quella del corpo-obeso suscita piuttosto vergogna e emarginazione.
Si tratta di una patologia tipica, anche se non esclusiva, delle società dette “del benessere”. L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce l’obesità attraverso l’indice di massa corporea (IMC), un dato biometrico che mette a confronto peso e altezza: sono considerati obesi i soggetti con IMC maggiore di 30 kg/m², mentre gli individui con IMC compreso fra 25 e 30 kg/m² sono ritenuti in sovrappeso. (Per una più completa trattazione della condizione clicca su http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?area=Malattie_endocrine_e_metaboliche&id=175)
UN CASO CLINICO
Rita è una donna di 45 anni, sposata, con due figli avuti in giovane età. Presenta un’obesità medio-grave, mostrando già a prima vista alcuni problemi dovuti alla sua condizione (capelli radi, respiro affannoso, ginocchia e caviglie gonfie). Il quadro clinico della paziente appare molto complicato e richiederebbe di essere seguito da un’équipe multidisciplinare; la persona comunica tuttavia di essere seguita solo dal suo medico curante, perché stanca di sottoporsi ai soliti regimi restrittivi, proposti negli ultimi anni dai nutrizionisti.
Rita racconta di non riuscire più a tollerare la situazione in cui si trova, si sente “vittima di attacchi improvvisi di fame. Mi abbuffo di nascosto, a volte mi accade anche quando sono in macchina, mi assale un senso di vuoto e mi fermo al primo supermercato disponibile per rimediare il cibo, generalmente i dolci. Sì,i dolci sono la mia droga e la mia rovina”.
Si descrive come una donna ‘piena di sensi di colpa’, ‘buona’, ‘sensibile’ e ‘molto fragile’: questa retorica è molto presente all’interno delle sue narrazioni. Rita desidera vivere più serenamente il suo rapporto con il cibo, smettendo di farsi del male con le abbuffate, perché consapevole di avere diversi problemi di salute; inoltre, vorrebbe riuscire a perdonarsi il suo ‘non essere una buona madre’. Già delle prima battute, Rita offre diversi spunti per intravedere e delineare possibilità di lavoro, rintracciate anche nelle contraddizioni del suo racconto.
Analisi dell’invio e del contesto di lavoro
Nel momento in cui un individuo chiede una consulenza ad un esperto, molto frequentemente, ha già elaborato una propria teoria sul suo disagio, sia che venga inviato da altri, sia che si presenti in modo autonomo, ed è molto importante per un buon funzionamento della terapia comprendere le ragioni dell’altro rispetto alla richiesta. Nel caso di Rita, il suo medico curante ha esplicitamente consigliato alla sua assistita di rivolgersi ad uno psicologo per affrontare il suo problema alimentare. Racconta di aver riflettuto molto prima di prendere la decisione di contattare un professionista e aggiunge che, ultimamente, la situazione le è scivolata ancora più di mano: “le abbuffate sono aumentate, sto proprio male in questo momento”.
Analisi del problema
Nel corso dei diversi colloqui, il lavoro è stato volto ad affrontare sia il disagio relativo alla propria corporeità che le problematiche vissute all’interno del contesto familiare. In un primo momento, si è cercato di comprendere la teoria della persona rispetto al problema e questo ha permesso di rintracciare due temi dominanti come risposta alle proprie sofferenze: il suo difficile passato, sia nel ruolo di figlia che di madre e il disturbo alimentare. La cliente ha lasciato subito intendere di aver avuto una vita molto complicata e dolorosa e, pertanto, le è stato chiesto di raccontare cosa portasse con sé di tutte quelle precedenti esperienze negative. L’obiettivo della domanda è volto a comprendere non solo le credenze di Rita, ma anche a raccogliere i punti di svolta del racconto, generativi di vissuti problematici.
La descrizione dell’identità di Rita, inizialmente, coincideva con il disturbo alimentare che raccontava come una presenza costante: “Non ho mai potuto fare quel viaggio, sono troppo grassa per mettermi in costume in quelle spiagge dorate” oppure “il tennis per me è sempre stata una passione, ma dalla tv ovviamente, visto come sono conciata non ho mai preso in mano una racchetta”.
Per questo il lavoro clinico è stato orientato ad ampliare le descrizioni di sé al fine di generare delle identità alternative. Un lavoro complesso e difficoltoso, anche perché Rita portava con sé una lunga biografia di interventi medici subiti ed un ampio repertorio di giustificazioni al suo disagio, molto complesso da perturbare (al di là del cibo, difficilmente sono riuscita a perdere più di qualche kg!).
Rita, inizialmente, mostrava delle posizioni ambivalenti rispetto all’esperienza con il cibo. Da una parte raccontava un irrefrenabile desiderio di abbuffarsi e dall’altra una forte paura di perdere il controllo. Il cibo assume pertanto una doppia valenza: diviene “l’oggetto del desiderio”, ma anche causa di numerosi sensi di colpa e conseguenti digiuni.
La rigidità nel percepirsi schiava di un impulso incastrava Rita nel ruolo di “malata”. Secondo la sua teoria, infatti, il senso di vuoto emotivo le procurava grave disagio a cui seguivano le abbuffate, come una sorta di anestetico contro i pensieri negativi. Perturbata la teoria sul problema, però, Rita ha iniziato a cogliere il suo ruolo attivo nella costruzione del sintomo riportato. Oltre a questo, si è rivelato opportuno trovare le eccezioni al problema nella sua esperienza di vita quotidiana con domande che hanno portato la cliente a rintracciare dei contesti vissuti che fossero caratterizzati da sensazioni di calma e tranquillità e nei quali sentiva di poter essere altro oltre alla donna malata.
Nel caso di Rita sperimentare l’idea di sé come persona che “riesce a controllare gli impulsi”, poteva generare uno spostamento da un ruolo predefinito, negativo e soverchiante, a quello di una persona in grado di autogestire le proprie esperienze emozionali. Nel succedersi degli incontri sono state esplorate in modo più approfondito le teorie sul problema, per comprendere cosa lo tenesse in piedi.
Risultati e valutazioni
La terapia risulta efficace nel momento in cui la persona riesce ad interconnettersi con la più ampia rete di relazioni e di contesti che la vedono coinvolta. Nel caso di Rita, che era imbrigliata in un costante gioco di auto-svalutazione, una parte della terapia è consistita nel creare degli scenari alternativi al problema, ricercando continuamente delle eccezioni che potessero sostenere il processo di decostruzione delle teorie disfunzionali di sé, per esempio in ambito lavorativo, è un abile ingegnere capace di districarsi in molti compiti.
Un’altra parte degli incontri si è soffermata sulle problematiche alimentari, per giungere poi ad una modificazione degli aspetti identitari ad essi correlati. Rita ha ampliato le metafore utilizzate per raccontare il suo disagio e ha guadagnato consapevolezza sui modi di narrarsi che la lasciavano senza alcuna possibilità di cambiamento. Rita si percepiva una persona “capace”, “solare”, “sicura”, “che fa la cosa giusta” e “meritevole di affetto” solo nel momento in cui riusciva a “vincere” sul cibo, mentre la perdita di controllo la rendeva una donna “stupida”, “debole”, “ingorda” e “una pessima madre e moglie”. Su questi punti è stato indispensabile ampliare le descrizioni di sé, anche e soprattutto per imparare a stimare il proprio valore indipendentemente dalla quantità di cibo ingerita (in famiglia è sempre stata bene e accettata, le sue erano paure di essere abbandonata).
Dopo un anno di lavoro, Rita sente di avere maggiore vicinanza affettiva con la figlia e ritiene di aver raggiunto il suo obiettivo più importante: quello di sentirsi una madre migliore attraverso il riconoscimento dei propri figli. Gli episodi di abbuffate sono scomparsi e il rapporto col cibo viene gestito con maggiore serenità e consapevolezza. Quando le accade di mangiare ancora qualche dolce, oggi lo riconosce come una concessione e una forma di golosità, ma non assume la misura e i connotati di un agito impulsivo finalizzato a riempire presunti vuoti emotivi. Il risultato è una significativa riduzione del peso corporeo che continua a mantenersi e a progredire nella direzione degli obiettivi auspicati.